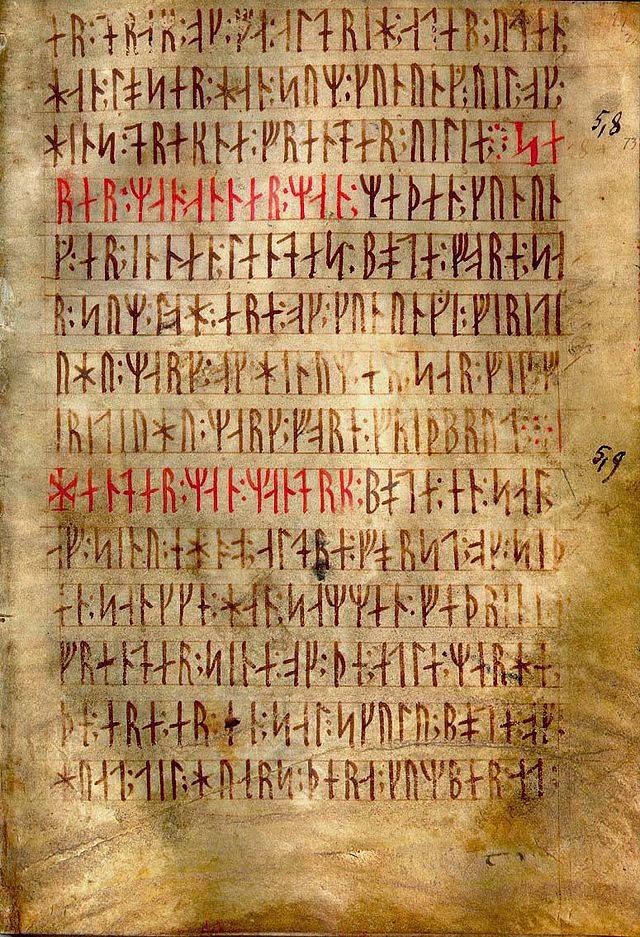Artemide è una delle dee più importanti della mitologia greca. Aveva numerosi attributi (talora fra loro contraddittori) e nomi, che le derivavano da un vasto processo di identificazione con le divinità femminili arcaiche di molti paesi del Mediterraneo.
Artemide, citando un Inno Omerico era: “Dea della caccia, vergine riverita, che uccide i cervi, saettatrice, sorella di Apollo dalla spada d’oro, che tra le colline ombrose e le cime ventose, godendo della caccia, tende il suo arco e scaglia dardi dolorosi.”
Dea della luna (per una tarda identificazione con Selene) era protettrice degli animali selvatici, dei bambini, delle vergini e delle persone indifese. Era però anche colei che uccideva di malattia le donne, come il gemello Apollo faceva con gli uomini.
Per questo motivo era anche associata, seppur non ufficialmente identificata, alla dea maga Ecate, detta l’Artemide dei crocicchi, legata al mondo dei morti e alla magia oscura.
Il legame tra Artemide e il noce è connesso ad una storia d’amore.
La dea vergine rifuggiva il contatto con gli uomini, che pagavano con la morte ogni oltraggio nei suoi confronti. Il cacciatore Atteone, ad esempio, reo di averla spiata mentre si bagnava nel fiume, fu trasformato in cervo dalla dea per evitare che potesse vantarsi di questa impresa e finì sbranato dai suoi stessi cani.
Sia detto per inciso, queste caratteristiche di forza ed autonomia della dea, ne hanno fatto un simbolo per molte femministe del novecento.
La dea amava circondarsi invece di fanciulle e ninfe votate alla verginità, con cui intratteneva rapporti di affettuosa e cameratesca amicizia. Quando una di queste fanciulle, Caria, morì, la dea pianse disperata finché il padre Zeus tramutò la fanciulla in noce. Da qui l’epiteto di Cariatide attribuito alla dea.
Il nome indicava anche le colonne dei templi a forma di ninfa. Inizialmente intagliate nel legno di noce, furono poi realizzate in pietra: per la prima volta nel Tesoro di Sifnos a Delfi (525 a.C.), in seguito nell’Eretteo di Atene.
I santuari di Artemide di norma erano situati fra i boschi, sulle montagne o sulle rive del mare, fuori dai terreni coltivati. La dea infatti simboleggiava la natura selvaggia in contrapposizione con la natura addomesticata dall'uomo mediante l'agricoltura. Per gli stessi motivi, probabilmente, la dea proteggeva i fanciulli e le vergini, due categorie di persone che, alla mentalità dell’epoca, dovevano apparire come “selvagge” e non ancora “addomesticate”, attraverso l’educazione e il matrimonio.
Il legame tra il noce e Artemide era presente anche in Italia, dove la dea fu identificata con varie divinità femminili italiche, tra le quali prese il sopravvento la romana Diana. Cerimonie in onore di Diana si svolgevano nei boschi e il nome della dea compare spesso nei processi per stregoneria, in quello che era chiamato “il gioco di Diana”, probabilmente un rituale di iniziazione delle giovani donne.
Non è possibile tacere un altro aspetto del culto di Artemide. Ad Efeso, in Jonia, era adorata una dea, chiamata Artemide/Diana che verosimilmente è collegabile anche all’antica dea anatolica Cibele. La Diana di Efeso, il cui tempio (Artemision) era una delle Sette Meraviglie del Mondo antico, aveva ben poche cose in comune con l’immagine della giovane e ascetica dea cacciatrice venerata in Grecia.
Era detta multimammia, per via delle innumerevoli mammelle che sporgevano dal suo petto nudo e le sacerdotesse dei suoi templi non facevano voto di castità, ma erano piuttosto esperte sacerdotesse dell’amore, che esercitavano la ierodulia (prostituzione sacra).
Tale attività era presente anche in alcuni santuari della Magna Grecia, ma non è chiaro se si sia diffusa anche nell’area sannitica (in cui era incluso Beneventum) dove era venerata la dea Diane.
Templi dedicati a Diana sono archeologicamente attestati nell’area beneventana, anche se non è chiaro quale forma assumessero le cerimonie in epoca romana.
Il nome di Benevento è però legato anche ad un’altra dea dagli inquietanti poteri magici.
Ma di Iside parleremo domani…